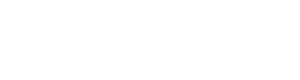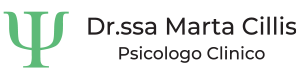04 Mag Cinema e Psicologia

DRIVE MY CAR
Titolo originale: Doraibu mai ka
Giappone 2021, col., 179’ di Ryusuke Hamaguchi
Con: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima, Park Yu-Rim, Jin Dae-Yeon, Sonia Yuan, Ahn Hwitae, Perry Dizon, Satoko Abe
Yusuke, attore teatrale, è sposato con Oto, sceneggiatrice che inventa le proprie storie mentre fa l’amore con il marito. In occasione di un inghippo il nostro protagonista rientra prima del solito a casa e trova la moglie che lo tradisce con un altro giovane attore. Tace e tiene tutto sotto silenzio, per timore di perdere l’amata, ma improvvisamente, causa un aneurisma, questa muore. Devastato dal dolore, durante una rappresentazione di Zio Vanja, Yusuke ammutolisce. Solo due anni dopo tornerà a teatro, ad Hiroshima, dove accetta di seguire la regia proprio del dramma di Cechov. Una strana regola della residenza artistica impone al Nostro di avere un autista, impedendogli di fare lunghi viaggi sulla sua Saab mentre era solito ascoltare un’ audiocassetta con la voce della defunta moglie che legge testi teatrali. Sarà il confronto con Misaki, la giovane autista segnata da un’infanzia difficile e che avrebbe la stessa età della figlia di Yusuke morta bambina, a comprendere a fondo se stesso, il rapporto che lo legava alla moglie e al testo di Cechov.
Tratto da un racconto di Murakami Haruki dal libro “Uomini senza donne”, un film non certo affine agli action movies attuali. Il tempo dilatato, ben rappresentato dalla notevole durata di circa tre ore, chiede allo spettatore di prendere confidenza con se stessi seguendo una storia, ricca di sottotesti, che si rivela essere un’epopea interiore, una ricerca di se stessi ed un tentativo di comprendere il proprio dolore. Di certo non basta una sola visione per seguire le infinità di tracce, più o meno celate nella superficie del testo, né basta un commento per cercare di riflettere su tutti i temi affrontati dal regista. Si vorrebbe, comunque lasciare alcune riflessioni, molto personali, su ciò che tale film può sollecitare.
Una prima riflessione è sul senso del linguaggio e sulla possibilità di comunicare e stare in relazione con un Altro. Si ricorda come Oto, in giapponese, significhi suono e rumore: di fatto la voce della donna, persa la sua corporeità, rimane come tale nelle cassette registrate e ascoltate continuamente dal protagonista. E sempre sulla voce e sul linguaggio si osserva come Yusuke imponga la lettura del testo teatrale di Zio Vanja con completa assenza di intonazione, con attori stranieri che recitano, ognuno, nella propria lingua madre (giapponese, mandarino, coreano fino alla lingua dei segni). La lingua è ridotta a puro significante e la relazione tra gli attori, l’immedesimazione degli stessi nei personaggi e nel testo, avviene solo attraverso il ritmo, sentendo il tempo giusto in cui intervenire, rispondendo emotivamente agli altri e creando rapporti nuovi. Al tempo stesso le parole si fanno più evanescenti, si ha un senso diverso, meditativo, delle pause e dei silenzi, fino a giungere alla lingua dei segni con cui l’attrice muta interpreta il famoso monologo finale di Sonja nella piece teatrale di Cechov.
Un altro aspetto che preme sottolineare è che se all’inizio Yusuke recita, fa l’attore, nella seconda parte dirige gli altri diventa regista, allo stesso tempo però, mentre all’inizio egli guida la sua auto, protagonista è la sua Saab 900 che, per ammissione stessa del protagonista, bisogna ben conoscere per guidare bene, è poi “guidato” dalla giovane Misaki. E’ nel momento del ribaltamento della guida, però che si apre una nuova consapevolezza: quando è la ragazza a guidare i dubbi ed il dolore di Yusuke sono lentamente elaborati. All’uso di inquadrature lunghe e medie che permettono comprendere diversi personaggi fanno eco piani stretti e primi piani dello spazio ridotto della Saab. Il gioco di distanza e vicinanza evocherebbe la distanza e la vicinanza delle relazioni con gli altri e con le proprie parti intime.
Dunque senza voler semplificare e banalizzare un film così articolato, complesso e poetico al tempo stesso, si può osare qualche similitudine con una psicoterapia, con un rapporto con un altro che si fa carico delle nostre pene e aiuta ad elaborarle, dove, al di là delle parole come mezzo necessario e fondamentale di comunicazione, esiste un quid, un legame affettivo, empatico che cura e si prende cura, in un Setting intimo che crea un campo emotivo ed esperienziale. Non facili soluzioni, non risposte predefinite, ma una relazione emotiva carica di speranza, la speranza espressa da Sonja nel testo di Checov e, come detto, recitata nella lingua dei gesti nel film: “… Noi, zio Vanja, continueremo a vivere. Trascorreremo una lunga serie di giorni, d’interminabili serate; sopporteremo pazientemente le prove che la sorte ci manderà; lavoreremo per gli altri e adesso e quando saremo vecchi, senza posa… E quando giungerà la nostra ora, noi morremo rassegnati e di là diremo che abbiamo sofferto, che abbiamo pianto, che abbiamo sentito tanta amarezza… e Dio avrà compassione noi…”